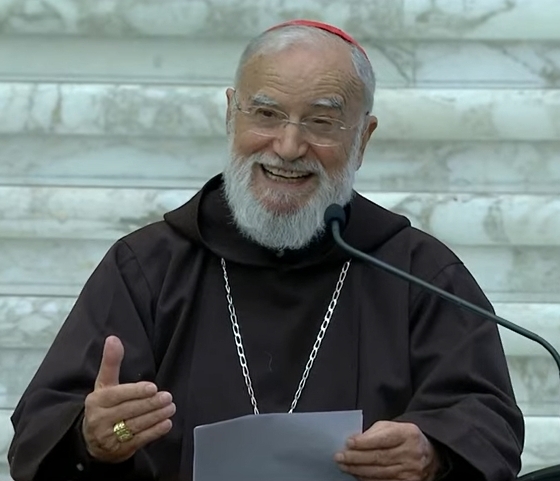
La storia della Chiesa di fine Ottocento e inizio Novecento ci ha lasciato una lezione amara che non dovremmo dimenticare per non ripetere l’errore che la provocò. Parlo del ritardo (anzi del rifiuto) di prendere atto dei cambiamenti avvenuti nella società, e della crisi del Modernismo che ne fu la conseguenza.
Chi ha studiato, anche superficialmente, quel periodo conosce il danno che ne derivò per una parte e per l’altra, cioè sia per la Chiesa che per i cosiddetti “modernisti”. La mancanza di dialogo, da una parte spinse alcuni dei più noti modernisti su posizioni sempre più estreme e per finire chiaramente ereticali; dall’altra, privò la Chiesa di enormi energie, provocando lacerazioni e sofferenze a non finire al suo interno, facendola ripiegare sempre di più su se stessa e facendole perdere il passo con i tempi.
Il Concilio Vaticano II è stato l’iniziativa profetica per recuperare il tempo perduto. Esso ha operato un rinnovamento che non è certo il caso di illustrare di nuovo in questa sede. Più che i suoi contenuti, ci interessa in questo momento il metodo da esso inaugurato che è quello di camminare nella storia, a fianco dell’umanità, cercando di discernere i segni dei tempi.
La storia e la vita della Chiesa non si è arrestata con il Vaticano II. Guai a fare di esso quello che si è tentato di fare con il concilio di Trento e cioè una linea di arrivo e un traguardo inamovibile. Se la vita della Chiesa si fermasse, succederebbe come a un fiume che arriva a uno sbarramento: si trasforma inevitabilmente in un pantano o una palude.
“Non pensare – scriveva Origene nel III secolo – che basti essere rinnovati una volta sola; bisogna rinnovare la stessa novità: ‘Ipsa novitas innovanda est’” . Prima di lui, il neo dottore della Chiesa sant’Ireneo aveva scritto: La verità rivelata è “come un liquore prezioso contenuto in un vaso di valore. Per opera dello Spirito Santo, essa ringiovanisce continuamente e fa ringiovanire anche il vaso che la contiene” . Il “vaso” che contiene la verità rivelata è la vivente tradizione della Chiesa. Il “liquore prezioso” è in primo luogo la Scrittura, ma la Scrittura letta nella Chiesa, che è poi la definizione più giusta della Tradizione. Lo Spirito è, per sua natura, novità. L’Apostolo esorta i battezzati a servire Dio “nella novità dello Spirito e non nella vetustà della lettera” (Rom 7,6).
Non solo la società non si è fermata al tempo del Vaticano II, ma ha subito una accelerazione vertiginosa. I mutamenti che un tempo avvenivano in un secolo o due, oggi avvengono in un decennio. Questo bisogno di continuo rinnovamento non è altro che il bisogno di continua conversione, esteso dal singolo credente alla Chiesa intera nella sua componente umana e storica. La “Ecclesia semper reformanda”.
Il vero problema non sta dunque nella novità; sta piuttosto nel modo di affrontarla. Mi spiego. Ogni novità e ogni cambiamento si trova davanti a un bivio; può imboccare due strade opposte: o quella del mondo, o quella di Dio: o la via della morte o la via della vita. La Didaché, uno scritto redatto mentre era ancora in vita almeno uno dei dodici apostoli, illustrava già ai credenti queste due vie.
Ora noi abbiamo un mezzo infallibile per imboccare ogni volta la via della vita e della luce: lo Spirito Santo. È la certezza che Gesú ha dato agli apostoli prima di lasciarli: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre (Gv 14, 16). E ancora: “Lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità” (Gv 16, 13). Non lo farà tutto in una volta, o una volta per sempre, ma a mano a mano che le situazioni si presenteranno. Prima di lasciarli definitivamente, al momento dell’Ascensione, il Risorto rassicura di nuovo i suoi discepoli sull’assistenza del Paraclito: “Riceverete –dice – la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra” (Atti 1, 8).
L’intento delle cinque prediche di Quaresima che oggi iniziamo, detto molto semplicemente, è proprio questo: incoraggiarci a mettere lo Spirito Santo nel cuore di tutta la vita della Chiesa, e, in particolare, in questo momento, nel cuore dei lavori sinodali. Raccogliere, in altre parole, l’invito pressante che il Risorto rivolge, nell’Apocalisse, a ognuna delle sette chiese dell’Asia Minore: “Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2, 7).
È l’unico modo, tra l’altro, che ho per non rimanere, io stesso, del tutto estraneo all’impegno in atto per il sinodo. In una delle mie prime prediche alla Casa Pontificia, 43 anni fa, dissi in presenza di san Giovanni Paolo II: “Io ho continuato a fare per tutta la vita l’umile mestiere che facevo da bambino”. E spiegai in che senso. I miei nonni materni coltivavano, a mezzadria, un vasto terreno collinoso. In giugno o in luglio c’era la mietitura, tutta a mano, con la falce, curvi sotto il sole. Era una fatica immane. Io e miei cuginetti eravamo incaricati di portare continuamente acqua da bere ai mietitori. È quello, dissi, che ho continuato a fare per il resto della vita. Sono cambiati i mietitori, che ora sono gli operai nella vigna del Signore, ed è cambiata l’acqua che ora è la Parola di Dio. Un mestiere, il mio, molto meno faticoso, a dire la verità, di quello dei lavoratori del campo, ma pure esso, spero, utile e in qualche modo necessario.
In questa prima predica mi limito a raccogliere la lezione che ci viene dalla Chiesa nascente. Vorrei mostrare, in altre parole, come lo Spirito Santo guidò gli apostoli e la comunità cristiana a muovere i primi passi nella storia. Quando furono messe per iscritto da Giovanni le parole di Gesú sopra ricordate sull’assistenza del Paraclito, la Chiesa ne aveva già fatto l’esperienza pratica, ed è proprio tale esperienza, ci dicono gli esegeti, che si riflette nella parole dell’evangelista.
Gli Atti degli apostoli ci mostrano una Chiesa che è, passo passo, “condotta dallo Spirito”. La sua guida si esercita non solo nelle grandi decisioni, ma anche nelle cose di minor conto. Paolo e Timoteo vogliono predicare il vangelo nella provincia dell’Asia, ma “lo Spirito Santo lo vieta loro”; fanno per dirigersi verso la Bitinia, ma, è scritto, “lo Spirito di Gesù non lo permette loro” (At 16, 6 s.). Si capisce, dal seguito, il perché di questa guida così incalzante: lo Spirito Santo spingeva in questo modo la Chiesa nascente ad uscire dall’Asia ed affacciarsi su un nuovo continente, l’Europa (cf. At 16,9). Paolo arriva a definirsi, nelle sue scelte, “prigioniero dello Spirito” (At 20,22).
Non è un cammino rettilineo e senza intoppi, quello della Chiesa nascente. La prima grande crisi è quella relativa all’ammissione dei gentili nella Chiesa. Non occorre rievocarne lo svolgimento. Ci interessa soltanto ricordare come viene risolta la crisi. Pietro va verso Cornelio e i pagani? E’ lo Spirito che glielo ordina (cf. At 10,19;11,12). E come viene motivata e comunicata la decisione presa dagli apostoli a Gerusalemme di accogliere i pagani nella comunità, senza obbligarli alla circoncisione e a tutta la legislazione mosaica? È risolta con quelle straordinarie parole iniziali: “È parso bene allo Spirito Santo e a noi…” (15, 28).
Non si tratta di fare dell’archeologia della Chiesa, ma di riportare alla luce, sempre di nuovo, il paradigma di ogni scelta ecclesiale. Non ci vuole molto sforzo infatti per scorgere l’analogia che c’è tra l’apertura che allora si operò nei confronti dei gentili, con quella che oggi si impone nei confronti dei laici, in particolare delle donne, e di altre categorie di persone. Vale la pena perciò rievocare la motivazione che spinse Pietro a superare le sue perplessità e a battezzare Cornelio e la sua famiglia. Leggiamo negli Atti:
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». (At 10, 44-47)
Chiamato a giustificare la sua condotta a Gerusalemme, Pietro racconta quello che era accaduto nella casa di Cornelio e conclude dicendo:
Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo!”. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? (At 11, 16-17).
Se guardiamo bene, è la stessa motivazione che spinse i Padri del Concilio Vaticano II a ridefinire il ruolo dei laici nella Chiesa, e cioè la dottrina dei carismi. Conosciamo bene il testo, ma è sempre utile richiamarlo alla memoria:
Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il Popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma ‘distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui’ (cf. 1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi opere ed uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle parole: ‘A ciascuno…la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio’ (1 Cor 12,7). E questi carismi, straordinari o anche più semplici e più comuni, siccome sono soprattutto adattati e utili alle necessità della Chiesa, si devono accogliere con gratitudine e consolazione .
Siamo davanti alla riscoperta della natura non solo gerarchica, ma anche carismatica della Chiesa. San Giovanni Paolo II, nella “Novo millennio ineunte”(nr. 45) la renderà ancora più esplicita definendo la Chiesa come gerarchia e come koinonia. A una prima lettura, la recente costituzione sulla riforma della Curia “Praedicate Evangelium” (al di là di tutti gli aspetti giuridici e tecnici sui quali sono un perfetto ignorante) a me ha dato l’impressione di un passo avanti in questa stessa direzione: cioè nell’applicare il principio sancito dal Concilio a un settore particolare della Chiesa che è il suo governo e a un maggiore coinvolgimento in esso dei laici e delle donne.
Ma adesso dobbiamo fare un passo avanti. L’esempio della Chiesa apostolica non ci illumina soltanto sui principi ispiratori, cioè sulla dottrina, ma anche sulla prassi ecclesiale. Ci dice che non tutto si risolve con le decisioni prese in un sinodo, o con un decreto. C’è la necessità di tradurre nella pratica tali decisioni, la cosiddetta “recezione” dei dogmi. E per questo occorrono tempo, pazienza, dialogo, tolleranza; a volte anche il compromesso. Quando è fatto nello Spirito Santo, il compromesso non è un cedimento, o uno sconto fatto sulla verità, ma è carità e obbedienza alle situazioni. Quanta pazienza e tolleranza ha avuto Dio, dopo aver dato il Decalogo al suo popolo! Quanto a lungo ha dovuto –e deve ancora – aspettare per la sua recezione!
In tutta la vicenda appena ricordata, Pietro appare chiaramente come il mediatore tra Giacomo e Paolo, cioè tra la preoccupazione della continuità e quella della novità. In questa mediazione, assistiamo a un incidente che ci può essere di aiuto anche oggi. L’incidente è quello di Paolo che ad Antiochia rimprovera Pietro di ipocrisia per aver evitato di sedere a tavola con dei pagani convertiti. Sentiamo l’accaduto dalla sua viva voce:
Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani; ma, dopo la loro venuta, cominciò a evitarli e a tenersi in disparte, per timore dei circoncisi (Gal 2, 11-12) .
I “conservatori” del tempo rimproveravano a Pietro di essersi spinto troppo oltre, andando dal pagano Cornelio; Paolo gli rimprovera di non essersi spinto abbastanza oltre. Paolo è il santo che ammiro e amo di più. Ma in questo caso sono convinto che si è lasciato trascinare (non è l’unica volta!) dal suo carattere di fuoco. Pietro non ha affatto peccato di ipocrisia. La prova è che, in altra occasione, Paolo farà, lui stesso, esattamente, quello che fece Pietro ad Antiochia. A Listra egli fece circoncidere il suo compagno Timoteo “a motivo –è scritto- dei giudei che si trovavano in quelle regioni” (At 16, 3), cioè per non scandalizzare nessuno. Ai Corinzi scrive di essersi fatto “giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei” (1 Cor 9, 20) e nella Lettera ai Romani raccomanda di venire incontro a chi non è ancora arrivato alla libertà di cui gode lui” (Rom 14, 1 ss).
Il ruolo di mediatore che Pietro esercitò tra le opposte tendenze di Giacomo e di Paolo continua nei suoi successori. Non certo (e questo è un bene per la Chiesa) in modo uniforme in ognuno di essi, ma secondo il carisma proprio di ognuno che lo Spirito Santo (e si presume i cardinali sotto di lui) hanno ritenuto il più necessario in un dato momento della storia della Chiesa.
Davanti agli eventi e alle realtà politiche, sociali ed ecclesiali, noi siamo portati a schierarci subito da una parte e demonizzare quella avversa, a desiderare il trionfo della nostra scelta su quella degli avversari. (Se scoppia una guerra, ognuno prega lo stesso Dio di dare la vittoria ai propri eserciti e annientare quelli del nemico!). Non dico che sia proibito avere preferenze: in campo politico, sociale, teologico e via dicendo, o che sia possibile non averle. Non dovremmo mai, però, pretendere che Dio si schieri dalla nostra parte contro l’avversario. E neppure dovremmo chiederlo a chi ci governa. È come chiedere a un padre di scegliere tra due figli; come dirgli: “Scegli: o me o il mio avversario; mostra chiaramente da che parte stai!” Dio sta con tutti e perciò non sta contro nessuno! È il padre di tutti.
L’agire di Pietro ad Antiochia – come pure quello di Paolo a Listra – non era ipocrisia, ma adattamento alle situazioni, cioè la scelta di quello che, in una certa situazione, favorisce il bene superiore della comunione. È su questo punto che vorrei continuare e concludere questa prima meditazione, anche perché questo ci permette di passare da quello che riguarda la Chiesa universale a quello che riguarda la Chiesa locale, anzi la propria comunità, o famiglia e la vita spirituale di ognuno di noi. (Che è quello che ci si attende, penso, da una meditazione quaresimale!).
C’è una prerogativa di Dio nella Bibbia che i Padri amavano sottolineare: la synkatabasis, cioè la condiscendenza. Per san Giovanni Crisostomo essa è una specie di chiave di lettura di tutta la Bibbia. Nel Nuovo Testamento questa stessa prerogativa di Dio è espressa con il termine benignità (chrestotes). La venuta di Dio nella carne è vista come la manifestazione suprema della benignità di Dio: “È apparsa la benignità di Dio e il suo amore per gli uomini” (Tito 3, 4).
La benignità –oggi diremmo anche cortesia – è qualcosa di diverso dalla semplice bontà; è essere buoni nei confronti degli altri. Dio è buono in se stesso ed è benigno con noi. Essa è uno dei frutti dello Spirito (Gal 5,22); è una componente essenziale della carità (1 Cor 13,4) ed è indice di animo nobile e superiore. Essa occupa un posto centrale nella parenesi apostolica. Leggiamo, per esempio, nella Lettera ai Colossesi:
Rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi (Col 3, 12-13).
Quest’anno celebriamo il quarto centenario della morte di un santo che è stato un modello eccelso di questa virtù, in un’epoca anch’essa segnata da aspre controversie: san Francesco di Sales. Dovremmo diventare tutti, in questo senso, “salesiani”: condiscendenti e tolleranti, meno arroccati sulle nostre personali certezze. Consapevoli di quante volte abbiamo dovuto riconoscere dentro di noi di esserci sbagliati sul conto di una persona o di una situazione, e di quante volte abbiamo dovuto adattarci anche noi alle situazioni. Nei nostri rapporti ecclesiali non c’è per fortuna – e mai ci dovrebbe essere – quella propensione all’insulto e al vilipendio dell’avversario che si nota in certi dibattiti politici e che tanto danno arreca alla pacifica convivenza civile.
C’è qualcuno, è vero, nei confronti del quale è giusto e doveroso essere intransigenti, ma quel qualcuno sono io stesso, è il mio io. Noi siamo portati, per natura, ad essere intransigenti con gli altri e indulgenti con noi stessi, mentre dovremmo proporci di fare proprio il contrario: severi con noi stessi, longanimi con gli altri. Questo proposito, preso sul serio, basterebbe da solo a santificare la nostra Quaresima. Ci dispenserebbe da ogni altro tipo di digiuno e ci disporrebbe a lavorare con più frutto e più serenità in ogni ambito della vita della Chiesa.
Un ottimo esercizio in questo senso consiste nell’essere onesti, nel tribunale del proprio cuore, nei confronti della persona con cui si è in disaccordo. Quando mi accorgo che sto mettendo sotto accusa qualcuno dentro di me, devo stare attento a non schierarmi subito dalla mia parte. Devo smettere di passare e ripassare le mie ragioni come chi mastica gomma, e cercare di mettermi invece nei panni dell’altro per capire le sue ragioni e quello che anch’egli potrebbe dire a me.
Questo esercizio non si deve fare soltanto nei confronti della singola persona, ma anche della corrente di pensiero con cui sono in disaccordo e della soluzione da essa proposta a un certo problema in discussione (nel Sinodo o in altro ambito). San Tommaso d’Aquino ce ne dà l’esempio: egli premette a ogni sua tesi le ragioni dell’avversario che mai banalizza o ridicolizza, ma prende sul serio e ad esse risponde poi con il suo “Sed contra”, cioè con le ragioni che ritiene le più conformi alla fede e alla morale. Domandiamoci (io per primo): facciamo così anche noi?
Gesù dice: “Non giudicate, per non essere giudicati. […] Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?” (Mt 7, 1-3). Si può vivere, ci domandiamo, senza mai giudicare? La capacità di giudicare non fa parte della nostra struttura mentale e non è un dono di Dio? Nella redazione di Luca, il comando di Gesù: “Non giudicate e non sarete giudicati” è seguito immediatamente, come per esplicitare il senso di queste parole, dal comando: “Non condannate e non sarete condannati” (Lc 6, 37). Non si tratta dunque di eliminare il giudizio dal nostro cuore, quanto di togliere il veleno dal nostro giudizio! Cioè l’astio, la condanna, l’ostracismo.
Un genitore, un superiore, un confessore, un giudice, chiunque ha una qualche responsabilità su altri, deve giudicare. Talvolta, anzi, il giudicare è, appunto, il tipo di servizio che uno è chiamato a esercitare nella società o nella Chiesa. La forza dell’amore cristiano sta nel fatto che esso è capace di cambiare segno anche al giudizio e, da atto di non-amore, farne un atto d’amore. Non con le nostre forze, ma grazie all’amore che “è stato effuso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato donato” (Rom 5,5)
Facciamo nostra, a conclusione, la bellissima preghiera attribuita a san Francesco d’Assisi. (Forse non è sua, ma ne riflette alla perfezione lo spirito):
O Signore, fa di me uno strumento della tua pace:
dove è odio, ch’io porti l’amore,
dove è offesa, ch’io porti il perdono,
dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dov’è dubbio, ch’io porti la fede,
dove è l’errore, ch’io porti la verità,
dove è la disperazione, ch’io porti la speranza,
dove è tristezza, ch’io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch’io porti la luce.
E aggiungiamo:
Dove c’è malignità ch’io porti benignità.
Dove c’è asprezza, ch’io porti gentilezza!
1.Cf. Origene, In Rom. 5,8; PG 14, 1042.
2.S. Ireneo, Adversus Haereses, III, 24,1.
3.Lumen gentium, 12.
(fonte: https://www.cantalamessa.org/?p=4059 )
